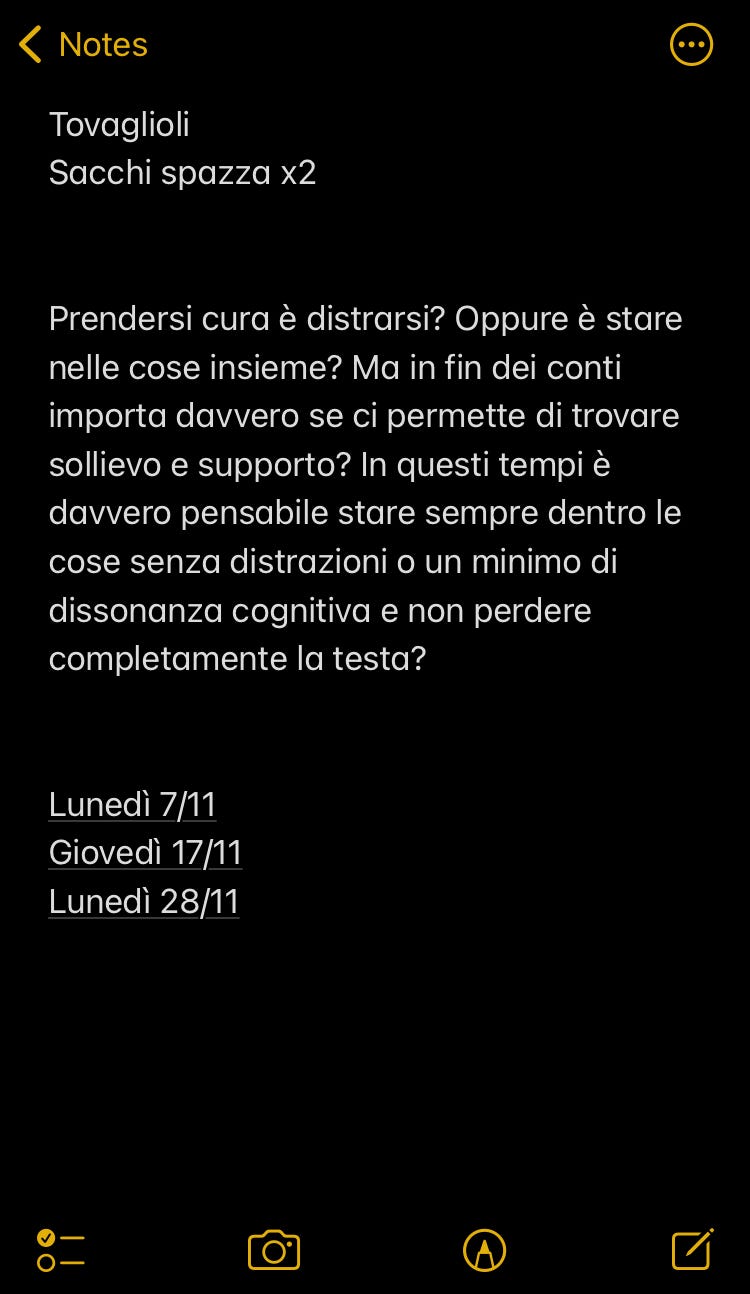#12
cura promiscua e zuppe
Benvenutə al dodicesimo numero di Interstizi,
una newsletter occasionale che nasce dal bisogno di mettersi insieme, di condividere riflessioni e pensieri fuori da uno spazio predefinito. Una piattaforma informale di confronto e di ricerca su arte, cultura pop e attualità che speriamo possa aprirsi nel tempo a tanti punti di vista e modalità espressive diverse. Uno spazio fisico e mentale per germogliare, condividere quello che ci sta a cuore, raccontare e raccontarsi, trovare la propria voce ma anche lanciarsi in qualche sano rant.
In questo numero ci facciamo gli auguri da sole 🎂 e ragioniamo un po’ insieme di lavoro di cura e capitalismo. Vi diciamo la nostra sull’annosa questione zuppe sopra i dipinti e cerchiamo di riassumere una quantità imbarazzante di vocali in qualche riflessione sparsa sull’ultima edizione della Biennale Arte di Venezia Il latte dei sogni. Ovviamente, cherries on top, o meglio, alla fine.
Buona lettura! 🌿
Fabiola & Giulia
Panorama
Cura promiscua
Siamo un po’ sparite. Il nostro secondo compleanno come newsletter è passato quasi inosservato, anche se è un bel traguardo. Non ci aspettavamo di andare avanti così tanto e di raccogliere così tante persone intorno a noi, che ci leggono e condividono e ci trovano nonostante la nostra difficoltà di stare sul pezzo come l’algoritmo richiederebbe. [Grazieee <3 ]
Dall’ultima volta che ci siamo sentitз sono successe parecchie cose nel mondo, come nelle nostre vite personali - sì, lo diciamo sempre, ma è sempre così e immaginiamo sia così per tantз, quindi siamo sicure capirete: il lavoro sembra sempre troppo per il tempo che abbiamo, alcuni problemi da affrontare nelle nostre vite personali sono complessi e i processi burocratici da affrontare per vivere ci fanno venire voglia di infilare la testa sotto la sabbia e far salire un po’ di sangue al cervello.
È cambiato un governo, non ci sono state grandi sorprese ma abbiamo comunque rabbrividito, mentre la rabbia ha iniziato a montare. Io (Giulia) l’ho dovuta buttare sulla satira, sulla risata, per riuscire in qualche modo ad affrontare lo sfacelo politico, sociale ed economico. Mi sono ritrovata più del solito nelle piazze e nei bar di Bologna, a sorseggiare aperitivi con amicз, cercando di dare un senso a tutto questo, in maniche corte e sudando a fine ottobre.
Io (Fabiola) l’ho osservata da lontano, con angoscia e rassegnazione, circondata da tantз colleghз e alleatз con cui ho scambiato riflessioni, speranze e racconti. La mia paura, le nostre analisi, i loro governi tanto inumani e spesso più violenti, più soffocanti, che in un modo forse perverso mi hanno fatto sentire meglio perché mi hanno ricordato che niente inizia e finisce, che tutte le nostre lotte sono connesse e in continuo divenire.
Un po’ per tutti questi motivi, un po’ perché si è già cominciato a parlare ossessivamente di maternità e natalità, in questo numero abbiamo deciso di parlare di ‘care’, di cura. Il lavoro di cura come spazio di conflitto, di sfruttamento, di isolamento. Ma anche, la cura come chiave delle più importanti relazioni umane, come strumento di sfogo e di sopravvivenza. Oltre al momento in cui stiamo vivendo, ci è sembrato importante parlare di cura proprio in occasione del nostro secondo compleanno e riflettere su come tutto il progetto Interstizi sia, in qualche senso, proprio nato da un’idea affine: ritrovarsi, ritagliarci uno spazio nostro ma non solitario, in cui prenderci del tempo per riflettere e per esprimerci senza dover dipendere da un sistema esterno in cui devi sempre dimostrare qualcosa a qualcuno (che hai le giuste conoscenze per pubblicare un articolo, che vali, che sei abbastanza cool ecc.).
La critical theory sulla cura è sempre più ampia e sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni, ma si tratta in realtà di concetti già trattati da tempo. Il lavoro di Foucault sulla cura del sé (1984); le numerose analisi sulla ‘crisi della cura’ nate in ambito neoliberista e nel dibattito postcoloniale; le prospettive femministe sul tema; le discussioni politiche sull’accesso alle cure (spesso connesse con l’accesso alla sanità); la cosiddetta ‘estetica della cura’ nel mondo dell’arte contemporanea… una veloce e imprecisa revisione della letteratura sul tema. Tra questi vari punti di riferimento, ci piace partire da Silvia Federici, che ha incentrato tutto il suo lavoro proprio attorno alla definizione del ‘lavoro di cura’: un lavoro che nel sistema capitalista è stato relegato alle donne, non salariato, riproduttivo invece che produttivo. Fondamentale per l’umanità ma completamente degradato. In Calibano e la strega (2004) Federici mappa il lento e complesso passaggio tra economia feudale e sistema capitalista, individuando uno degli strumenti principali di questo processo nell’assoggettamento al lavoro di cura delle donne attraverso la repressione di ogni forma di organizzazione di collettività alternative tramite la caccia alle streghe e altri strumenti persecutori.
Negli anni Settanta la seconda ondata del movimento femminista prende ad elemento centrale l’idea che il lavoro domestico debba essere retribuito - Wages for Housework (un movimento di cui Federici è, ancora una volta, una delle fondatrici) - in quanto elemento chiave nel funzionamento e nella produzione di valore nel sistema capitalista. Un’esperienza non priva di conflitti interni e discussioni ma che ha definito un orizzonte politico fondamentale per la lotta femminista e che echeggia nelle piazze ancora oggi.
Lo stesso tema viene ampiamente affrontato e rappresentato da diverse artiste femministe negli Anni Settanta. Nel cortometraggio Semiotics of the Kitchen (1975) Martha Rosler mette in scena una dimostrazione di utensili da cucina in un ibrido tra televendita e programma di cucina. Passando in rassegna i vari strumenti in ordine alfabetico, la sua interazione fisica con gli oggetti diventa man mano più violenta e sprezzante e con risvolti volontariamente ironici. Attraverso questa gestualità aggressiva, Rosler fa emergere la violenza insita nei concetti della donna in cucina, la donna casalinga, il focolare domestico, raccontando la frustrazione che si nasconde dietro il linguaggio d’amore con cui si parla solitamente del lavoro domestico. Nello stesso anno, Birgit Jürgenssen realizza Hausfrauen – Küchenschürze [Grembiule da cucina per casalinghe], lavoro fotografico in cui la Jürgenssen stessa si ritrae mentre indossa una cucina portatile che sembra inghiottire il corpo dell’artista, fondendo la sua persona con i suoi obblighi di cura e rendendo in modo efficace l’invisibilizzazione e deumanizzazione insita in determinati discorsi. Contemporaneamente, in Italia Milli Gandini organizza la mostra/evento La mamma è uscita (1975), realizzata in collaborazione con il Comitato per il lavoro domestico salariato; un appello a non cedere al ricatto emotivo della famiglia, identificato come strumento privilegiato attraverso cui il capitale sfrutta questo 'lavoro d'amore'. Gandini traccia simboli e slogan femministi nella polvere lasciata ad accumularsi su mobili e superfici, mentre scolapasta e pentole vengono "sabotati" e resi inutilizzabili. Nell'opera la casa diventa un campo di battaglia in cui Gandini mette in scena l'abbandono dello spazio domestico e lo sciopero generale immaginato dal Comitato.
Nell'attuale contesto economico e culturale, il lavoro di cura acquisisce una nuova centralità dal momento in cui ci troviamo in uno stato di crisi che Nancy Fraser ha definito nel saggio Crisis of Care? On the Social-Reproductive Contradictions of Contemporary Capitalism proprio come ‘crisi della cura’, interpretata come espressione di una serie di contraddizioni e limiti del capitalismo. Dopo anni di politiche di austerity e privatizzazione dei servizi essenziali, è proprio nell’ambito della cura che si vedono con maggior forza gli effetti e le fragilità del sistema. In quest’ottica, tutto il lavoro di cura, e non solo quello domestico non retribuito, è degradato e ‘femminizzato’: personale delle pulizie, caretakers, infermierз, docentз, qualsiasi lavoro che richieda esplicitamente empatia e attenzione verso le esigenze dellз altrз è di norma sottopagato e pubblicizzato da annunci declinati esclusivamente al femminile. Lavoro a parte, le donne sono socializzate e cresciute con un senso di responsabilità sugli altri e sulla loro cura molto più spiccato e pesante degli uomini. Abbiamo tuttз storie aneddotiche di come in famiglia le aspettative che le figlie femmine tenessero la propria stanza in ordine oppure aiutassero con i lavori domestici fossero estremamente alte, a fronte di una grande tolleranza verso i maschi.
Di recente Silvia Federici è intervenuta ad una conferenza di Rice Architecture proprio sulla tematica della cura, evidenziando come durante la pandemia le donne sono state la maggioranza delle persone licenziate dalle aziende in crisi, oppure ad abbandonare volontariamente il lavoro per gestire la presenza dei figli in casa durante il giorno. Federici ha anche evidenziato come, nonostante le donne consumino più farmaci antidepressivi e tranquillanti, i suicidi siano piuttosto rari rispetto agli uomini, proprio perché fin dall’infanzia le donne sono abituate a sentire sulle proprie spalle la responsabilità della famiglia e delle altre persone della loro vita. Elsa Dorlin definisce dirty care (cura sporca) il fenomeno per cui i membri di una minoranza oppressa tendono a sopprimere i loro bisogni e la loro capacità di agire per sviluppare una profonda comprensione dei loro oppressori così da prevenire qualsiasi forma di violenza e, dunque, difendersi. Dietro l’idea di propensione si nasconde dunque un processo storico lunghissimo in cui le donne (soprattutto) hanno dovuto imparare ad adeguarsi a determinati ruoli per poter sopravvivere e restare parte della società.
Questa cura può diventare una devastante fonte di ansia e preoccupazione, in cui tutto viene prima che il proprio benessere psicofisico. Abbiamo già toccato altre volte, in questa newsletter, sull’idea di self-care, di cura di sé, un concetto particolarmente abusato dal femminismo da social network e dalle aziende che lo utilizzano per vendere i loro prodotti. La cura di sé è talmente sminuita dal marketing e da Instagram, ridotta alla cura della pelle, al bere acqua e limone la mattina presto e farsi le unghie, che la sua potenza viene spesso persa. Ma la verità è che quando non stiamo bene non riusciamo prima di tutto a prenderci cura di noi stessз: è la prima cura che sacrifichiamo per aiutare unə altrə e quella che viene a mancare in momenti di profondo disagio psicofisico. Parlando di questo articolo con la nostra amica Victoria (che conoscete già dalla nostra rubrica Ciliegie), le è venuto in mente che nel suo romanzo L’arte della gioia (1994) Goliarda Sapienza scrive che essere una brava persona è in fin dei conti un privilegio: significa poter avere le risorse, il tempo e la lucidità mentale di avere cura di qualcun altro, cosa molto più complessa quando si è tarati sulla mera sopravvivenza. Françoise Vergés analizza il modo in cui il privilegio, soprattutto quando si parla di classe e razza, influisca sulla distribuzione delle attività di cura, mettendo a confronto i concetti di pulizia e sporcizia, in cui il primo corrisponde al ‘corpo sano e di successo’, spesso bianco e borghese, mentre il secondo viene utilizzato per parlare dei corpi razzializzati e che si occupano materialmente di pulire, accudire, cucinare all’interno di famiglie, aziende e strutture e che permettono a tuttз lз altrз di potersi prendere effettivamente cura di se stessз, di non doversi preoccupare di una serie di incombenze.
Ci sembra un discorso incredibilmente rilevante in questo momento storico, e anche nelle nostre vite. Pandemia, guerra (e spettro di uno scontro nucleare), crisi climatica, inflazione e tutte le apocalissi in cui, nostro malgrado, ci troviamo a vivere ci stanno sempre più prosciugando collettivamente.
Come scrivono lз autorз di The Care Manifesto (2020), Our world is one in which carelessness reigns - viviamo in un mondo in cui il menefreghismo regna. Per quanto non mi senta di difenderlo, se mi (Giulia) metto a pensare il più trasversalmente possibile, l’egoismo mi sembra una reazione valida e possibile alla situazione in cui viviamo. Di recente, su un volo Ryanair, mi sono ritrovata a pensare che, dato che viaggiare come ci siamo abituati a fare potrebbe non essere possibile tra non troppo tempo, mi debba sbrigare a visitare alcuni posti che davvero voglio vedere nel mondo. Godersi quello che si può prima che ‘finisca la pacchia’, insomma.
Guardare al nostro orticello rende le cose più maneggevoli e ci dà un (falso) senso di controllo sulla realtà. Ma, allo stesso tempo, sono proprio l’egoismo, la mancanza di empatia, l’idea che mettere se stessз al primo posto sia sempre e comunque la scelta migliore ad averci portato alla situazione attuale, con società fortemente polarizzate e un dibattito pubblico sempre più aggressivo e dai toni violenti e pieni di disprezzo.
A questo si è aggiunto, personalmente e collettivamente tra le nostre amicizie, crescere. I problemi diventano più difficili, le ansie più brutte, si iniziano ad accusare i colpi dello stress, i familiari si ammalano perché iniziano ad invecchiare… il lavoro di cura (e di cura del sé) è stato molto nei nostri pensieri e nelle nostre vite. Viviamo in società che tendono, inoltre, a renderci sempre più isolatз, a farci vergognare di stare male, a sovraccaricarci tuttз così tanto che a volte non abbiamo le energie di aiutare qualcunə altrə.
Mi sono anche trovata a sentirmi in colpa. Un appunto tra le note del mio telefono, che ho trascritto sulla prima stesura di questo articolo, è stato: Prendersi cura è distrarsi? Oppure è stare nelle cose insieme? Ma in fin dei conti importa davvero se ci permette di trovare sollievo e supporto? In questi tempi è davvero pensabile stare sempre dentro le cose senza distrazioni o un minimo di dissonanza cognitiva e non perdere completamente la testa?
Nel suo ultimo saggio, On Freedom (2021), Maggie Nelson riflette sulla cura, soprattutto in relazione all’arte e all’estetica e ad un certo punto scrive: “Caretaking, the reparative, making life more liveable and humane for us all - all of these things matter enormously. But, for better or for worse, they are not all. For many - perhaps even most - life feels more ample, more liveable, wider and more various.” Ovvero: “Prendersi cura, i gesti riparatori, rendere la vita più vivibile e umana per tutti noi - tutte queste cose contano moltissimo. Ma, nel bene o nel male, non sono tutto. Per tante persone, forse per tutte, la vita sembra più ampia, più vivibile, più vasta e varia.” Nel mio senso di colpa ho ritrovato molto di quanto scritto da Nelson, che descrive quello che è il peso della cura: una ragnatela di fili invisibili in cui non pensare solo a noi stessз può portarci tanto benessere ma anche diventare sfiancante, in cui non c’è solo utopia ma effettiva difficoltà, in cui prenderci cura di qualcuno o qualcosa ci pesa, ci costringe a compiere scelte che rendono la nostra vita più piccola e ripetitiva, che ci costringono in un ambito morale più rigido e asfissiante.
Una delle esperienza di cura più belle che ho fatto nell’ultimo anno è stato prendere un orto urbano. È un duro lavoro, soprattutto con la siccità incredibile che ha colpito il Nord Italia, ma anche perché rompere le zolle di terra con la zappa è (spoiler alert) molto faticoso. Eppure prendersi cura di una piccola striscia di terra, ararla, concimarla, riempirla di ortaggi e fiori, vederli crescere, prosperare, attirare api e dare frutti mi ha riempito di una felicità simile a quella che provavo da bambina. Il mio rapporto con l’orto è diventato d’ispirazione per altri rapporti della mia vita basati sulla cura: mettere un gran lavoro, attenzione e dedizione, e ricevere ‘in cambio’ serenità e stabilità. Nonostante la fatica, i momenti passati all’orto mi sembrano più vicini ad una sensazione di libertà e di fare qualcosa per me che ad una costrizione o ad un lavoro.
A volte la cura può anche essere un momento di pausa, ritagliato insieme a qualche amicə oppure per se stessз. Abbiamo già scritto dell’amicizia e di come, per la nostra generazione precaria e (generalmente) senza figli, questi rapporti stiano diventando un cardine sempre più importante attorno a cui si lega il lavoro di cura. La creazione di comunità in cui l’amicizia basata su uno scambio di risorse, emozioni, opinioni e forza è uno dei pochi strumenti in cui sentiamo che la cura si possa davvero sviluppare appieno e che ci permette effettivamente di sopravvivere in un mondo sempre più complesso, con minacce sempre più severe, politiche sovraniste e antiprogressiste, aumento della povertà, della precarietà e dell’isolamento individuale.
Mi capita sempre più spesso di parlare con amicз di quando avremo una nostra comune, un nostro posto immerso nella natura e gestito esattamente come vogliamo. Con alcunз sono fantasticherie di quando saremo in pensione (lol, mai, ma anche, meglio mangiare licheni da un bosco che lavorare fino a 70+ anni); con altrз una romanticizzazione dell’epoca post-apocalittica in cui viviamo.
Ho ritrovato questi progetti (più o meno realistici) nella conclusione del talk di Federici per Rice Architecture, in cui la studiosa ci esorta a ritrovare l’incanto del mondo, a creare forme di cooperazione capaci di rompere l’isolamento in cui viviamo, a recuperare la nostra relazione con la natura e gli animali andando oltre l’ottica di mercificazione che ci è stata inculcata fin da bambinз. L’unico modo per creare relazioni basate su uno scambio solidale e di creare legami forti con l’altrə è andare al di là di una società competitiva, in cui se qualcuno vince noi stiamo necessariamente perdendo e in cui siamo portati a pensare al nostro benessere come una priorità assoluta, senza preoccuparci troppo dei costi effettivi e di chi li pagherà.
Fotoromanzo
Il 14 ottobre 2022 Phoebe Plummer e Anna Holland, due attiviste dell’organizzazione Just Stop Oil, che si batte contro il cambiamento climatico e per la riduzione e cessazione dell’uso di combustibili fossili, hanno svuotato una lattina di zuppa al pomodoro sopra i Girasoli (1888-89) di Van Gogh, conservato alla National Gallery di Londra. In seguito le attiviste hanno incollato una mano alla parete, prima di venire staccate dalla polizia e arrestate. Il dipinto è uno dei più celebri conservati alla National Gallery, apprezzato e conosciuto anche al di fuori dei circoli dell’arte e dal valore stimato di 84,2 milioni di dollari.
La notizia ha fatto il giro del mondo e ha infiammato i social, anche perché molte pubblicazioni che hanno riportato la notizia (tra cui, ad esempio, anche l’agenzia Ansa) hanno inizialmente omesso che il quadro non ha subito nessun danno, in quanto protetto da un vetro. L’intento dell’azione non era quella di vandalizzare un’opera d’arte, ma proprio di generare scalpore e finire sulle prime pagine. Come dichiarato in seguito al Guardian, lз attivistз erano andatз in precedenza alla National Gallery a sincerarsi che il dipinto fosse protetto.
Intervistata a seguito dell’azione Phoebe Plummer ha posto la domanda, Is art worth more than life? More than food? More than justice? - L’arte ha davvero più valore della vita? Del cibo? Della giustizia?
La dichiarazione completa sul sito di Just Stop Oil.
Qualche giorno dopo, il 23 ottobre 2022, l’organizzazione tedesca Letze Generation (l’ultima generazione), ha inscenato una simile azione presso il museo Barberini di Potsdam, in Germania. Due attivisti hanno lanciato del purè di patate contro il celebre dipinto Les Meules (1890-91) di Claude Monet e si sono poi incollati al muro. Anche in questo caso il dipinto, protetto dal vetro, non ha riportato alcun danno (e, anche in questo caso, molti media sono stati ambigui al riguardo, suscitando inutile sdegno). Les Meules è stato acquistato nel 2019 da un collezionista privato per 110 milioni di dollari e poi esposto in prestito presso il museo.
Una dellз attivistз coinvoltз nell’azione ha dichiarato: “Siamo di fronte ad una catastrofe climatica e tutto quello che vi fa paura è un po’ di zuppa di pomodoro”
Queste azioni si inseriscono in un’attivazione molto più grande e globale che si sta articolando in una serie di azioni all’interno di spazi pubblici e commerciali. Qui potete trovare un video riassuntivo realizzato da Amnesty.
Se da un lato prendere di mira opere d’arte di artisti celebri e cari a moltissime persone porta sicuramente l’attenzione desiderata, dall’altro molte persone si limitano a criticare l’azione senza riflettere sulle reali motivazioni dei gruppi che le organizzano.

Non è la prima volta che i musei diventano un luogo di protesta. Già nel 1914, la suffragetta Mary Richardson attacca con un coltello La Venere allo specchio (1650) di Diego Velázquez per protestare contro l'arresto di Emmeline Pankhurst. Più recentemente, restando sul tema dell’attivismo ambientalista, il gruppo Liberate Tate (che si definisce un collettivo di arte e attivismo) ha fatto particolare scalpore con una serie di azioni all’interno dell’omonomo museo per denunciare i legami tra la Tate e la multinazionale British Petroleum (BP), all’epoca uno dei suoi maggiori finanziatori, e chiedere al museo di interrompere la partnership con l’azienda - scissione che è poi avvenuta nel 2016. La scelta del museo non è dunque una scelta casuale e se da una parte risponde sicuramente al valore culturale e storico dell’istituzione, dall’altra deriva da specifici rapporti di potere (e di denaro).

L’accento posto sull’arte è sicuramente interessante: un’industria multimiliardaria, che rappresenta in modo sostanziale le élite mondiali, con un mercato gonfiato e assolutamente sconnesso con la realtà. Il modello produttivo dell’arte si basa attualmente su operazioni economiche che hanno molto a che fare con investimenti e speculazione finanziaria e molto poco con la creazione di benessere collettivo; ogni anno una quantità insensata di eventi porta le persone-dell’arte a prendere aerei per esserci, essere visti, essere nel posto giusto al momento giusto. Un sistema poco sostenibile che sembrava essere stato messo in crisi dalla pandemia ma che è tornato a pieno regime, e anzi più splendente del solito, come visto in occasione della Biennale di Venezia o la più recente Frieze London. Sui social tante persone si sono scandalizzate per le azioni portate avanti da questi gruppi, anche con toni particolarmente rabbiosi, ma viene naturale porsi delle domande davanti a questa indignazione collettiva: Qual è oggi il ruolo dell’arte? Dove sono queste persone quando il patrimonio viene sistematicamente svenduto o abbandonato dalle istituzioni e dalla politica? Che tipo di relazione persiste tra fruitorз ed immagine e perché continua ad esistere una venerazione cieca ed acritica verso determinati oggetti-icona? A chi serve questa idea di arte?
Come riassunto nel tweet che abbiamo incluso in questo fotoromanzo, pensiamo sia più problematico continuare a supportare un sistema completamente sconnesso dalla realtà, in cui l’1% continua ad arricchirsi alle spalle di tuttз. Bisogna sganciarsi dalla venerazione dell’arte e tornare a vivere la cultura come pratica politica, espressione del reale e del presente, qualcosa che è di tuttз e per tuttз e di cui ci dobbiamo interessare sempre, non solo quando sentiamo il bisogno di sfogare la nostra frustrazione su attivistз. Non sappiamo se questo sia il modo più efficace per portare avanti la protesta ambientalista o quanto queste metodologie riescano ad attivare un discorso che vada oltre l’evento. È innegabile però che queste azioni siano solo una parte di un movimento che negli anni continua a svilupparsi su più fronti, cercando di utilizzare ogni mezzo per arrivare al più numero di persone possibile, di entrare nei palazzi del potere, di influenzare policy globali. Ed è innegabile, anche, il fatto che il cambiamento climatico stia assumendo proporzioni sempre più concrete, spaventose e irreversibili. Ma tutto questo sembra svanire davanti all’ennesimo meme su zuppe campbell e girasoli.
A fuoco
Abbiamo visitato (purtroppo non insieme) The Milk of Dreams, la 59esima Biennale d’arte di Venezia, curata da Cecilia Alemani. Il titolo, Il latte dei sogni, è ripreso da un libro di favole scritto e illustrato dall’artista surrealista Leonora Carrington, che “descrive un mondo magico nel quale la vita viene costantemente reinventata attraverso il prisma dell’immaginazione e nel quale è concesso cambiare, trasformarsi, diventare altri da sé".
Oltre al Surrealismo, un’altra evidente influenza teorica sull’esposizione è quella di accademiche quali Rosi Braidotti e Donna Haraway, sia nei testi di accompagnamento che nelle reference delle artistз, nelle loro opere e nelle estetiche spiccatamente post-umane. Partendo da una serie di domande sull’evoluzione dell’idea e definizione di umano e le nostre responsabilità verso il mondo e i più-che-umani, le tematiche principali includono la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi, la relazione tra individui e tecnologie (divenire-macchina), e gli intrecci tra corpi e Terra (divenire-terra).
La mostra, come sempre enorme e piuttosto travolgente, raccoglie i lavori di 231 artistз provenienti da 58 nazioni, di cui circa 180 alla prima partecipazione e, per la prima volta in una Biennale, di cui solo 21 uomini. I lavori in mostra si focalizzando sulla contemporaneità, ma la curatrice ha anche incluso diverse sezioni storiche con lavori di fine Ottocento e prima metà del Novecento.
Come dichiarato dalla stessa Alemani all’interno del catalogo, l’intento di questa Biennale è stato quello di produrre una mostra transtorica, che riuscisse a riscrivere il canone della storia dell’arte, includendo voci e sguardi tradizionalmente marginalizzati.
Ci siamo confrontate molto su questa Biennale, sulle nostre sensazioni, riflessioni e opinioni (hello, vocali di 3 minuti su whatsapp), che vogliamo condividere con voi.
***
Giulia: Mi è piaciuto molto che la base di tutta la mostra sia un testo di narrativa surrealista e che non ci ho trovato solo teoria nel senso stretto, anche se chiaramente c’è un forte apparato teorico ben inserito in una tradizione accademica femminista e/o queer - comunque fuori da un certo tipo di visione scientifico-illuminista, occidentale ed eteronormativa.
Come sai sono molto attratta dall’idea del magico, dell’inspiegabile, di quello che va al di là dell’umano in senso stretto ma che, allo stesso tempo, è fortemente parte dell’essere umano; quei sistemi di pensiero e rappresentazione che si sono sviluppati in parallelo alla scienza e da essa derisi, come se davvero si potesse conoscere e spiegare e controllare tutto.
Fabiola: L’assetto surrealista è molto forte e riesce a posizionare la mostra all’interno di un immaginario e un’atmosfera molto chiara. Guardando alle domande iniziali che vengono poste nel testo curatoriale - Come sta cambiando la definizione di umano? Quali sono le differenze che separano il vegetale, l’animale, l’umano e il non-umano? Quali sono le nostre responsabilità nei confronti dei nostri simili, delle altre forme di vita e del pianeta che abitiamo? E come sarebbe la vita senza di noi? - mi sembra che il magico diventi però un po’ un escamotage per parlare di crisi reali in un luogo altro, allontanando l’urgenza e gli aspetti più politici e materiali dei temi trattati. Ho apprezzato molto il discorso postumano sull’interdipendenza e la simbiosi, ma mi sembra che la selezione delle opere in mostra si sia orientata soprattutto verso forme di alleanza tra umani e più-che-umani, evitando di includere esempi e riflessioni su solidarietà, classe, mutuo soccorso. Capisco la scelta ma soffro un po’ questa ‘astrazione’. Mi è sembrata una Biennale ammaliante ✨✨✨ che riesce a coniugare le urgenze del presente e il nostro bisogno di temi politici e rappresentazioni inclusive con il gusto del mercato.
Giulia: Non l’ho assolutamente vista come una biennale ‘politica’, e che quantomeno neppure avesse le pretese di esserlo, e questo è stato un altro aspetto che ho apprezzato. Sicuramente alcuni lavori singoli affrontano tematiche politiche, vedi ad esempio (uno tra i molti) il lavoro di Simone Leigh esposto all’ingresso dell’Arsenale, ma nel contesto generale della mostra sicuramente altri elementi più narrativi, poetici ed artistico-estetici sono messi in evidenza rispetto al valore politico che diverse opere in realtà hanno. Sono d’accordo sul fatto che la mostra non articoli effettive proposte o idee di nuove alleanze collettive, non ce n’è l’ombra e neppure la pretesa.
Per me l’intento che più è apparso evidente è stato quello di celebrare pratiche artistiche che sono state semi ignorate dal mainstream dell’arte contemporanea per parecchio tempo e che adesso, per nuove sensibilità, teorie, e in parte nuovi movimenti politici, stanno venendo alla ribalta. Ah, ovviamente l’attenzione che il mercato sta dimostrando nei confronti di questa tipologia di lavori è centrale - stiamo pur sempre parlando della più importante mostra d’arte contemporanea al mondo.
Una problematica alla base di tutta la mostra potrebbe proprio essere il fatto che un’operazione decisamente unica - una Biennale con il 90% di artistз donne o non binary, e con una buona presenza di artistз con punti di vista non occidentali - sia di fatto stata inquadrata come operazione storico-artistica. La presenza di sezioni storiche volte proprio a revisionare il passato e cambiare attivamente il canone (di cui parliamo meglio più avanti) per me lo dimostrano.
Fabiola: concordo con te, non è una biennale politica e, anzi, Alemani non ha mai dichiarato lo fosse, ma si può parlare dei legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra senza posizionarsi politicamente? Mentre camminavo tra le opere e i padiglioni mi sono costantemente chiesta attraverso quali occhi e archivi del sapere stavo guardando questi lavori e ho trovato evocativo che sulla copertina delle edizioni ITA e EN della guida breve ci siano due occhi. Guardare ed essere guardati, oltre il concetto di gaze ma proprio come riflessione sul proprio posizionamento nel mondo.
Giulia: è una domanda molto interessante e può essere appunto una criticità. Credo che si possa farlo, che si possa parlare di questi legami in modo poetico, narrativo e surrealista, ma che nei tempi in cui viviamo questo ci sembri allo stesso tempo insincero e inaccettabile, perché vogliamo un’arte che ci dica qualcosa di più. Anche se mi sto sempre più convincendo che questo non debba essere necessariamente un compito dell’arte, o perlomeno di tutta l’arte.
Guardando proprio al mondo dell’arte direi che non ci sono state grandi sorprese: è stata una Biennale che ha raccolto una serie di trend in atto da diversi anni, come una ritrovata attenzione verso il Surrealismo e le artiste meno conosciute di questo movimento (la Tate Modern sta sfornando mostre al riguardo dal 2015 circa in poi). Un altro elemento centrale della Biennale, come del mondo e del mercato dell’arte più attuali, è la predilezione per lavori molto ‘materici’, relegando a contorno il video, le video installazioni e in parte anche la fotografia, dopo anni di trionfo di questi media.
Per me la tematica preponderante o comunque più interessante è stata proprio quella del corpo, nei suoi intrecci surreali e misteriosi con l’esterno e con il suo stesso interno, nella sua inscrutabilità e nelle sue contaminazioni molto diverse con la tecnologia e con la natura.
Fabiola: Il corpo, una presenza quasi inevitabile lungo tutta la mostra. Sproporzionati, modellati nell’argilla, ricomposti, mutilati, espansi, distorti. Corpi femminili, corpi non-binari, corpi ibridi, corpi cyborg. Corpi liberi e corpi imprigionati. Devo confessare di essermi sentita sopraffatta da questa sollecitazione fisica e visiva. Ho trovato molto interessante il modo in cui la mostra abbia raccolto forme di rappresentazione e rivendicazione, alcune estremamente potenti, come il lavoro Counterblaste (2021) di Gabrielle L’Hirondelle Hill, in cui l’artista parla di identità e del processo di "mercificazione del subalterno" attraverso la creazione di una figura ibrida umano-coniglio costruita con collant imbottiti di tabacco, un materiale fortemente simbolico in quanto utilizzato come oggetto rituale e di scambio nelle comunità indigene ma anche bene di esportazione/espropriazione dal periodo coloniale ad oggi. Tuttavia, la presenza di alcuni lavori importanti, che evidenziano il corpo come spazio di negoziazione e lotta, non riesce a sostenere un impianto curatoriale eccessivamente essenzialista, che riafferma una determinata percezione dell’identità e dell’arte ‘femminile’, così come una determinata idea di lotta, ancora troppo legata all’identità fine a se stessa. Non sarà esattamente la stessa cosa, e mi rendo conto che qui la citazione o il parallelismo è molto molto tirato (ma siamo tra di noi no?), ma questa sovrabbondanza di corpi mi ha fatto pensare al famoso slogan delle Guerrilla Girls: Le donne devono per forza essere nude per entrare al (Met) Museo? So che parliamo di altri tipi di usi e percezioni del corpo, di rivendicazioni e ribaltamenti di sguardo, ma mi sembra ci sia un continuo ritorno agli stessi schemi iconografici e identitari che alla fine invece di liberarci ci intrappolano ancora di più.
Parlando di corpi e cyborg, ho trovato molto belle ed efficaci le capsule storiche [dal titolo La culla delle streghe, Tecnologie dell’incanto, Corpo Orbita, Una foglia una zucca un guscio una rete una borsa una tracolla una bisaccia una bottiglia una pentola una scatola un contenitore, La seduzione del cyborg]. La selezione di opere, artiste, documenti e riferimenti riesce ad approfondire e sedimentare i temi della mostra principale e a creare connessioni trans-storiche inaspettate, recuperando artistз e figure storiche particolarmente iconiche. Già dalla prima ‘stanza’ ho pensato che le capsule ricordassero molto gli allestimenti tradizionali del museo illuminista, sia nella scelta delle teche che dei colori e materiali, e questa intuizione è stata confermata nel catalogo in cui viene dichiarato che le capsule sono pensate proprio per attivare “una riflessione sulle modalità con cui la storia dell’arte viene costruita e su come certi dispositivi museali ed espositivi stabiliscono gerarchie di gusto e meccanismi di inclusione ed esclusione.” Forse sarebbe stato interessante provare a sperimentare altri metodi di storicizzazione che mettessero in discussione l’idea di canone e canonizzazione, così come quella di genio o icona.
Giulia: Sono molto d’accordo sulla qualità delle capsule storiche e sulla qualità dell’allestimento rispetto a tutte le altre edizioni della Biennale che ho potuto vedere, e che ho percepito essere stato davvero ‘curato’ e pensato. Di per sé le capsule sono state una grossa novità, in allontanamento della mission più classica della Biennale di mostrare “l’arte adesso”.
La canonizzazione alternativa, o forse meglio dire parallela, e l’allargamento del canone a me sono proprio sembrati l’intento principale di questa Biennale, più che un contro. Guardando al contesto della Biennale e alla stessa carriera di Alemani come figura fortemente inserita in un certo sistema dell’arte contemporanea, non mi aspettavo niente di diverso e, anzi, una simile operazione va in una direzione che per me è più realistica. Non la sparizione del canone, ma l’allargamento del canone, progressivo ma così inevitabile che ad un certo punto si arriverà alla sparizione del canone. Per quanto io personalmente sia più a favore di un’esplosione dell’idea stessa di canone, già superare l’idea di canone alternativo/parallelo e allargare il canone vero e proprio per me è un enorme passo avanti nel panorama contemporaneo. E non sono neppure sicura che ci siamo riuscite.
Un’osservazione che ho avuto sulle stesse capsule sfogliando poi il catalogo è stato il fatto che queste sezioni siano rimaste prettamente eurocentriche, nonostante una maggiore presenza di punti di vista al di fuori dal contesto occidentale nella mostra principale, e proprio questo mi ha fatto riflettere sull’intento, conscio o subconscio che sia stato, di utilizzare queste sezioni proprio come strumento di canonizzazione in senso più tradizionale.
Leggendo a posteriori alcune recensioni o dibattiti critici, la reazione più comune è stata la sorpresa, come di fronte a qualcosa di davvero esotico: ma non avevo mai visto questз artistз, dove sono state nascoste, wow! (hiding in plain sight…). Quando non proprio becero rigetto, come nella recensione di Jackie Wullschäger sul Financial Times, di cui ho potuto leggere praticamente solo la citazione (qui) per via del contenuto a pagamento, “by choosing almost exclusively women, Alemani has paid a severe price in terms of quality” (ma sembra già molto chiaro così: scegliendo quasi esclusivamente donne, Alemani ha pagato un prezzo molto elevato per quanto riguarda la qualità dei lavori in mostra). Cioè, siamo ancora qui. Ho letto anche in un’altra recensione che il rischio maggiore è che, al netto di un effettivo movimento del mercato e delle istituzioni in direzioni aperte da questa Biennale, il rischio maggiore è che in poco tempo - giusto un paio di edizioni delle fiere Frieze e Art Basel - tutto questo venga dimenticato. Che si ritorni al vero e proprio canone, che questa mostra passi alla storia come “la Biennale delle donne”, e che così venga raccontata nei curricula universitari.
Credo sia una previsione abbastanza probabile, anche se spero di no.
Ciliegie
i nostri pick culturali
🍒 Podcast 🍒
Death of an Artist, la storia dell’omicidio dell’artista Ana Mendieta e di come il mondo dell’arte continui a celebrarne l’assassino. Quando smetteremo di usare la genialità come giustificazione e scudo della violenza? Raccontato dalla storica dell’arte Helen Molesworth.
Per approfondire sul mercato dell’arte e sulla sua attuale salute e connessioni con il potere globale consigliamo questo episodio di Today in Focus, il podcast quotidiano del Guardian.
Molto interessante anche l’ultima puntata di Politics, podcast gratuito del Post, dove Annalisa Camilli (giornalista di Internazionale) interviene sulle ‘nuove’ vecchie politiche del governo riguardo alle migrazioni via rotta mediterranea.
🍒 Letture 🍒
Un romanzo: Generazione slut, libro autobiografico della sex writer e mille altre cose Karley Sciortino che condivide senza troppi giri di parole il suo rapporto con il sesso, il lavoro sessuale, le fantasie che non ci diciamo e quelle che ci non ci saremmo mai aspettatз. Un libro forse poco sensibile, a volte fastidioso, ma estremamente liberatorio.
Un saggio: Having and being had di Eula Biss, edito in italiano da Luiss University Press con il titolo Le cose che abbiamo. Essere e avere alla fine del capitalismo, è a metà tra un diario e un saggio, una riflessione molto personale su che cosa vuol dire possedere qualcosa (ed esserne possedutз) elaborata dall’autrice a seguito dell’acquisto della sua prima casa.
Un classico: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, edito da Feltrinelli, si è trattato per me di una prima lettura. È un libro sfacciatamente maschilista, ma è anche un libro di frasi iconiche e in cui ogni parola sembra messa al suo posto con la precisione di un gioielliere che incastona una pietra.
Un articolo: Un articolo di Kwame Anthony Appiah su classe e meritocrazia - particolarmente attuale, no?
Privatizzare l'utopia di Ale/Sandra Cane, come riassume perfettamente il sottotitolo: Gucci, desiderio e appropriazione
Infine, Elon Musk è arrivato a distruggere Twitter e non possiamo che chiederci Are We Living Under 'Technofeudalism'? La risposta è ovviamente sì.
Misc: Un’interessante riflessione su abuso e conflitto nella Ghinea di settembre e questa rivista online molto bella
🍒 Musica 🍒
È successa questa cosa magica, è uscito il nuovo album dei Verdena con un tour praticamente sempre sold out. Bello amicз, tutto tanto bello. Così come ci sono piaciuti molto When Everything Is Better, I'll Let You Know di Pip Millet e Where I'm Meant to Be di Ezra Collective.
🍒 Film 🍒
A cura di Victoria Chuminok <3
Babysitter di Monia Chokri (2022). A causa di un video virale dove molesta una giornalista, Cedric, viene sospeso dal lavoro e si ritrova a riflettere in maniera bizzarra e stereotipata sulla sua misoginia e il ruolo degli uomini nell’oppressione delle donne (dialoghi con il fratello tipo: “sono femminista ma …” lol). Le loro riflessioni sono seguite dallo sguardo assente, a causa della depressione post parto, della compagna Nadine, rilegata al ruolo domestico di cura del loro figlio che continua a piangere ininterrottamente. L’equilibrio dei ruoli crolla con l’assunzione di una disinibita babysitter.
La scelta di Anne (L’événement), di Audrey Diwan (2021). Un film che non sono ancora riuscita di vedere ma sento di voler consigliare in quanto affronta il tema dell’aborto, che dal non molto lontano 1978 (in Italia) ad oggi non possiamo considerare come un diritto conquistato di cui servirci nel caso di necessità. Leone d’Oro come miglior film alla Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia 78, racconta la storia di Anne che vuole interrompere una gravidanza indesiderata in un Paese privo di una legge che tuteli la scelta di abortire e fa ricadere tutte le responsabilità e la vergogna sulla protagonista femminile.
El Pianeta, Amalia Ulman (2021). Amalia Ulman è un’artista argentina di base negli Stati Uniti, lavora con il video, la performance e la net-art, mezzi che utilizza per mettere in mostra il narcisismo della nostra contemporaneità (per capire meglio il suo lavoro qui). In questo suo primo lungometraggio indaga il rapporto tra madre e figlia nel pieno di una crisi. Per chi si trova a Bologna questa domenica all’Odeon ;)
🍒 L’Internet 🍒
Sempre a tema film UbuWeb, una libreria ‘ombra’ che contiene centinaia di migliaia di video, film e opere d'avanguardia scaricabili gratuitamente.
Forgotten Heritage, database nato come progetto di ricerca sugli artisti d'avanguardia provenienti da Polonia, Croazia, Belgio ed Estonia, con un focus sugli anni '60 e '70 e che si sta allargando ora a nuovi Paesi e nuovi focus di ricerca.
J.K. Rowling ha spezzato il cuore di tutti i millenial con le sue affermazioni (e azioni) transfobiche ma è solo una piccola parte del problema. ContraPoints ci spiega meglio cos’è il ‘femminismo’ gender critical.
La nostra personale crociata contro crypto e NFT continua.
Che cos’è il Classismo digitale? E i jet dei ricchi.
Auto-aiuto, again? La nostra wiki-page. La nostra serata tipo. Le nostre verità.
****************************************************************
Noi siamo arrivate alla fine di questo dodicesimo numero di Interstizi.
Grazie per essere arrivatə fin qui, per averci letto, per averci dedicato del tempo.
Interstizi è in fase di sperimentazione permanente quindi se avete suggerimenti, feedback o volete semplicemente condividere con noi cosa vi passa per la testa potete rispondere a questa mail, seguirci su Instagram o scriverci a interstizinewsletter@gmail.com - se invece sei qui per sbaglio ma vuoi saperne di più puoi iscriverti qui sotto:
Interstizi è un progetto a cura di Fabiola Fiocco e Giulia Pistone.